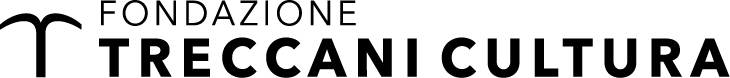Proprio per questo le donne hanno esigenza di passare da un punto all’altro della città velocemente e con tempi ben scanditi. La maggior parte della popolazione femminile tende a spostarsi a piedi o utilizzando mezzi pubblici, molto più di quanto lo facciano gli uomini. In Francia l’utenza dei servizi di trasporto pubblico è composta per due terzi da donne; a Philadelphia e a Chicago le percentuali sono rispettivamente pari al 64 percento ed al 62 percento.
Inoltre, il tragitto che compiono gli uomini e le donne, che sia a piedi o con diversi mezzi di trasporto, sono sostanzialmente differenti, perché differenti sono le loro abitudini di vita. Le donne in genere svolgono il 75% del lavoro di cura non retribuito, percentuale che varia a seconda dei paesi: in Italia è il 74%. Questo le obbliga a percorrere pattern di strade diversi, molto più complessi e che, nella maggior parte dei casi, non sono diretti verso il centro della città, area solitamente meglio organizzata e più facilmente raggiungibile. Dunque, se gli uomini solitamente, in una giornata infrasettimanale, compiono il tragitto casa-lavoro e viceversa, le donne seguono quello che viene chiamato trip-chaining: una modalità di viaggio composta da più tappe concatenate. I mezzi, però, nella maggior parte dei casi non sono pensati per questo tipo di spostamento, che richiede spesso tappe in aree della città mal collegate o dove i mezzi pubblici passano con bassa frequenza.
Lo svantaggio che vede coinvolte le donne è dato principalmente da una mancanza di dati di genere, nel caso specifico di un’assenza di prospettiva. Il gender gap dei dati sulla mobilità risulta essere evidente anche nella tendenza di molti studi a trascurare gli spostamenti brevi a piedi e con mezzi “non motorizzati”. I quali, secondo la docente di urbanistica all’Università di Madrid Inés Sanchez de Madariaga, «non sono considerati rilevanti nella definizione delle politiche infrastrutturali». Inoltre, ignorare gli spostamenti brevi a piedi, aggrava ancora di più il vuoto di dati sul trip-chaining, in quanto questa modalità comporta solitamente almeno un tratto a piedi. Asserire l’irrilevanza dei tratti brevi sulle politiche infrastrutturali potrebbe suggerire l’immagine dell’irrilevanza delle donne in quest’ambito.
Un grande aiuto e servizio per le donne sarebbe l’utilizzo di servizi di car-sharing, come ad esempio Uberpool o altre aziende similari. Il problema che sorge è che questo tipo di servizi ha un costo oneroso, che si fa ancora più evidente sulle donne, che solitamente dispongono di un accesso al patrimonio familiare minore. La disparità di genere varia, secondo il The Global Gender Gap, da Paese a Paese, 18,1 nel Regno Unito, 23 in Australia, 59,6 nella Repubblica di Angola.
Il McKinsey Global Institute ha calcolato che il lavoro di cura delle donne contribuisce per circa diecimila miliardi di dollari al Pil annuo mondiale, ma, nonostante ciò, la credenza che vede la mobilità connessa al lavoro retribuito prioritaria rispetto alla mobilità di chi compie a titolo gratuito un lavoro di cura continua ad essere molto popolare, in particolar modo tra coloro che progettano i piani urbanistici.
Un altro fattore che contribuisce all’incremento del Pil è il lavoro retribuito femminile. Affinché le donne possano lavorare occorre una città che le sostenga, che sia alla loro portata. È necessario, dunque, un sistema di trasporti che permetta loro di coniugare lavoro retribuito e lavoro non retribuito, facendole arrivare puntuali in ufficio, dopo aver portato i figli a scuola.
Un’ulteriore problematica che si vedono costrette ad affrontare le donne durante l’utilizzo dei mezzi pubblici è la paura. Questo fatto induce sicuramente le donne a modificare il loro comportamento e le loro abitudini, alcune arrivano anche al punto di rinunciare al lavoro pur di non dover più essere esposte a quella sensazione durante il tragitto. Come in altri casi, anche in questo la causa principale è quella della mancanza dei dati di genere. Infatti, le statistiche ufficiali, secondo Anastasia Loukaitou-Sideris, professoressa di urbanistica presso l’Università della California, raccontano solo una parte della verità. Le donne si trovano quotidianamente ad essere esposte a condotte maschili che hanno il preciso scopo di farle sentire a disagio. Dai fischi di ammirazione, agli sguardi lascivi, dagli insulti a sfondo sessuale ai tentativi di abbordaggio. Nessuno di questi comportamenti ha un’effettiva valenza criminale, ma contribuiscono tutti a creare una costante sensazione di minaccia. L’invisibilità dei gesti minacciosi rivolti alla popolazione femminile negli spazi pubblici è aggravata dal fatto che i molestatori agiscono quando le donne sono sole; infatti, gli eventuali accompagnatori uomini, quando ci sono, hanno molta meno probabilità di essere coinvolti.
Purtroppo, le donne tendono a non denunciare molte molestie che ricevono principalmente per due motivi: in primo luogo, non conoscono a chi rivolgersi e spesso non sanno se l’atteggiamento di cui sono state vittime è abbastanza grave da essere denunciato; in secondo luogo, spesso entra in gioco la vergogna, la paura di un possibile isolamento sociale.
La mancanza di dati è causata non solo dalla mancanza di denunce, ma anche dal fatto che questi comportamenti rientrano solo in pochissimi casi nelle statistiche sulla criminalità.
La domanda che sorge spontanea è perché le aziende di trasporto, visti i numerosi casi di molestia, non hanno ancora provveduto a raccogliere dati disgregati per genere. Questo contribuisce al già difficile inserimento delle donne nel mercato del lavoro, in quanto molte di loro sfruttano proprio i mezzi pubblici per raggiungere l’ufficio e per spostarsi con i bambini. Dunque, una maggiore attenzione alla sicurezza e alla gestione del trasporto pubblico gioverebbe non solo alla parte della popolazione femminile, ma senza dubbio anche a quella maschile.
Inoltre, in un mondo in cui la disparità di genere è un tema molto discusso, rivedere l’assetto urbanistico delle città così da agevolare anche la popolazione femminile sarebbe un forte segnale di sviluppo e progresso verso una città più giusta ed equa. Ovviamente, oltre a produrre migliori dati e statistiche, un aspetto fondamentale è legato alla necessità di dare più rappresentanza alle donne in tutti gli ambiti della vita. Perché, man mano che queste conquistano nuove posizioni, di prestigio o di potere, diventa sempre più evidente che, a differenza dei loro colleghi uomini, esse hanno ben presenti le esigenze delle donne.
La soluzione al vuoto dei dati sul genere femminile è chiara: colmare il vuoto di rappresentanza. Quando sono coinvolte nei processi decisionali, nella ricerca scientifica, nella produzione di conoscenza o nella pianificazione urbana, le donne non restano sepolte nell’oblio. La loro presenza fa uscire dall’ombra le prospettive femminili, e questo è un vantaggio per l’intera umanità. Dopotutto, la risposta a Freud e al suo “enigma della femminilità” è sempre stata davanti agli occhi di tutti. Basta chiedere alle donne.
Per saperne di più:
Criado Perez, Caroline, Invisibili, Torino, Einaudi, 2020.
Mazzette, Antonietta, Estranee in città: a casa, nelle strade, nei luoghi di studio e di lavoro, Milano, FrancoAngeli, 2009.